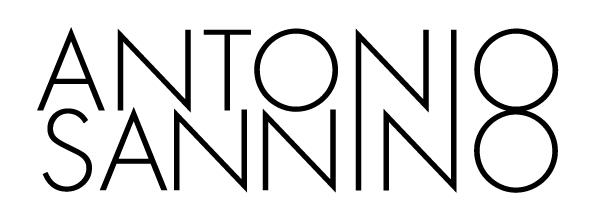Hanami. Antonio Sannino è il miracolo della rifioritura
Non desidero soffermarmi sulla questione dell’Hanami, letteralmente “guardare i fiori”, un termine giapponese che fa riferimento all’usanza di pellegrinare nei luoghi dove più intensa e straordinaria è la fioritura primaverile degli alberi di ciliegio, e che Antonio Sannino sceglie come titolo di questa sua ultima monografia. Una monografia che fin dalla copertina e poi in un’ampia sezione interna riporta i lavori di Sannino dedicati al tema dei sakura. Ovviamente l’Hanami evoca una moltitudine di metafore resistenti nella filosofia orientale e più in generale radicate anche nella nostra civiltà. Innanzitutto, il “guardare”: come fosse il mondo uno spettacolo, abbiamo il compito di guardarlo, un compito che il pittore si assume con maggior coscienza degli altri uomini. La pittura infatti è per prima cosa un guardare, perfino quando essa è astratta, perfino quando ciò che si guarda è dentro di noi. E solo attraverso la vista, che è un guardare intensificato dalla ragione, ci appare la bellezza. Poi, “i fiori” che sono il fenomeno esperibile immediato della natura, simboli di rinascita certo, ma pure di effimero stare; la loro connatura finitezza, la loro pervicace transitorietà, eppure il loro ripresentarsi nonostante tutto, esaltano l’ambivalenza dell’esistere e dello scorrere del tempo che è ciclico per certe cose e unidirezionale per altre. I fiori rifioriscono ogni anno con la stessa gioiosa intensità e giovinezza, noi siamo invece destinati ad invecchiare; i fiori muoiono molte volte e rinascono, noi nasciamo e moriamo una sola volta.
Se tralasciamo per un attimo il dato concettuale, possiamo concentrarci sulla questione estetica: Sannino nel solco più antico del lavoro del pittore, si limita a riprodurre la cosa per ricordarla e fissarla nel tempo, così come esperiva Plinio riferendosi alla figlia del vasaio Butade che tracciò i contorni dell’ombra prodotta dal profilo dell’amato il giorno prima che egli partisse e da questo atto d’amore nacque la pittura. Ed effettivamente la pittura non è altro che questo: o amorevolmente rammemorare, o pietoso svelare. Sannino si attiene a questo, un duplice sforzo: rappresentando i fiori dei ciliegi, rammemorandoli li preserva dalla nientificazione del tempo, da loro annullamento, e al contempo li fa apparire, manifestandone la bellezza emblematica. Non li mummifica, non li mette sotto formaldeide, perché lo scopo dell’artista non è preservare il reale in sé, l’artista non è un imbalsamatore di corpi né di fiori, bensì ne fa metafore o quando vi riesce simboli. E qui interviene lo stile di un artista, necessariamente legato all’epoca in cui vive, perché se non fosse così sarebbe bastata la prima natura morta a contenere tutte le altre. E invece ogni generazione di artisti si ostina a trovare la soluzione formale più utile a significare sempre la stessa cosa, perché come scrive Rilke “c’è sempre da guardare”. Sannino sembra ispirarsi alla prospettiva piatta della pittura giapponese, ma intensificata da un close up tanto intenso da non lasciare spazio, sui supporti in alluminio di grandi dimensioni, a null’altro che non sia il colore bianco rosato rosa intenso quasi viola dei petali. I rami sono azzurri e sembrano fiumi, o meglio arterie che solcano un’immensa superficie rossa conducendo un fluido pastoso e innervando i petali, quasi che il punto di vista dell’artista per osservare i ciliegi non sia stato, come ci si potrebbe aspettare, dal basso all’alto oppure frontale, bensì dall’alto verso il basso, e ci trovassimo di fronte a una veduta aerea di una porzione di foresta, a una sorta di mappa geografica. In questo depistamento visivo c’è la forza di una serie di opere che superano gli ultimi tentativi pittorici di Damien Hirst, dedicati similmente ai “Cherry Blossom”, nei quali appaiono gli alberi in fiore nelle consueta prospettiva, prospettiva che dà ai suoi lavori un irrimediabile senso di déjà vu, cose già viste ma meno riuscite rispetto a quelle dei tanti predecessori nella storia dell’arte moderna (basti pensare agli “Almond blossom” di Van Gogh). La poetica di Sannino, invece, rimanda sempre a una compressione del reale negli spazi della finestra-quadro, ad una sua spettacolarizzazione nei termini soprattutto del colore: i suoi mari, le sue foreste, i panorami urbani riflettono sempre questa eccitazione visiva che, contrariamente ad Hirst, non è di maniera, semmai una vera necessità espressiva.
Nel caso degli Hanami c’è però anche tutta la storia che il termine giapponese trascina con sé e che riguarda la capacità dell’arte di creare metafore persistenti. Nel caso dell’Occidente, è la mitologia che fin dagli albori istruisce con Persefone, la dea della primavera, il nostro bisogno di comprendere il mondo, e l’alternarsi delle stagioni, e i ritmi di vita e morte. In Oriente, soprattutto in Giappone, è spesso la poesia a dar corpo a questa esigenza. Innumerevoli haiku e hokku, le stringate composizioni in 17 sillabe, molti saigo no uta, i versi di commiato dei guerrieri condannati al suicidio rituale, associano il fiore del ciliegio alla inappartenenza e alla provvisorietà del visibile, tipica della filosofia buddhista e poi zen in cui l’essere è mera apparenza e dolore dal quale possiamo allontanarci solo esperendo il vuoto e lo zero. Matsuo Bashō, il più grande poeta giapponese del Seicento, o più tardi tra Settecento e Ottocento, il monaco buddista Daigü Ryōkan, hanno cantato la rinascita, la morte, la caducità, attraverso il fiore del ciliegio e più in generale dei fiori: “Lentamente/ come la neve/ che scende dal cielo/ sembrano cadere/ i fiori del ciliegio”; “Questo mondo/ è simile all’eco/ che risuona/ e poi svanisce/ nell’aria”; “Come scrivere/ numeri sull’acqua/ è cosa vana/ affidarsi ciecamente/ al proprio cuore”; e ancora “Tutto nel mondo/ è transitorio/ e ogni essere/ va incontro/ alla morte”.
“Ogni incontro è separazione” sentenzia in limine Ryōkan; noi dal mondo, noi dalle cose. Al fondo resta però fulgida la parola che resiste e in cui riponiamo inalterata fiducia, resta il dipinto che sottrae la vita alla morte. Sannino in qualche modo riesce, attraverso l’arte, nel miracolo della rifioritura così come aveva indicato, già nel Cinquecento, il grande Arakida Moritake, autore della celebre raccolta 1000 haikai: “Un petalo caduto/ che torna al ramo:/ una farfalla”.
di Angelo Crespi
Hanami. Antonio Sannino è ił miracolo della rifioritura
Non desidero soffermarmi sulla questione dell’Hanami, letteralmente “guardare i fiori”, un termine giapponese che fa riferimento all’usanza di pellegrinare nei luoghi dove più intensa e straordinaria è la fioritura primaverile degli alberi di ciliegio, e che Antonio Sannino sceglie come titolo di questa sua ultima monografia. Una monografia che fin dalla copertina e poi in un’ampia sezione interna riporta i lavori di Sannino dedicati al tema dei sakura. Ovviamente l’Hanami evoca una moltitudine di metafore resistenti nella filosofia orientale e più in generale radicate anche nella nostra civiltà. Innanzitutto, il “guardare”: come fosse il mondo uno spettacolo, abbiamo il compito di guardarlo, un compito che il pittore si assume con maggior coscienza degli altri uomini. La pittura infatti è per prima cosa un guardare, perfino quando essa è astratta, perfino quando ciò che si guarda è dentro di noi. E solo attraverso la vista, che è un guardare intensificato dalla ragione, ci appare la bellezza. Poi, “i fiori” che sono il fenomeno esperibile immediato della natura, simboli di rinascita certo, ma pure di effimero stare; la loro connatura finitezza, la loro pervicace transitorietà, eppure il loro ripresentarsi nonostante tutto, esaltano l’ambivalenza dell’esistere e dello scorrere del tempo che è ciclico per certe cose e unidirezionale per altre. I fiori rifioriscono ogni anno con la stessa gioiosa intensità e giovinezza, noi siamo invece destinati ad invecchiare; i fiori muoiono molte volte e rinascono, noi nasciamo e moriamo una sola volta.
Se tralasciamo per un attimo il dato concettuale, possiamo concentrarci sulla questione estetica: Sannino nel solco più antico del lavoro del pittore, si limita a riprodurre la cosa per ricordarla e fissarla nel tempo, così come esperiva Plinio riferendosi alla figlia del vasaio Butade che tracciò i contorni dell’ombra prodotta dal profilo dell’amato il giorno prima che egli partisse e da questo atto d’amore nacque la pittura. Ed effettivamente la pittura non è altro che questo: o amorevolmente rammemorare, o pietoso svelare. Sannino si attiene a questo, un duplice sforzo: rappresentando i fiori dei ciliegi, rammemorandoli li preserva dalla nientificazione del tempo, da loro annullamento, e al contempo li fa apparire, manifestandone la bellezza emblematica. Non li mummifica, non li mette sotto formaldeide, perché lo scopo dell’artista non è preservare il reale in sé, l’artista non è un imbalsamatore di corpi né di fiori, bensì ne fa metafore o quando vi riesce simboli. E qui interviene lo stile di un artista, necessariamente legato all’epoca in cui vive, perché se non fosse così sarebbe bastata la prima natura morta a contenere tutte le altre. E invece ogni generazione di artisti si ostina a trovare la soluzione formale più utile a significare sempre la stessa cosa, perché come scrive Rilke “c’è sempre da guardare”. Sannino sembra ispirarsi alla prospettiva piatta della pittura giapponese, ma intensificata da un close up tanto intenso da non lasciare spazio, sui supporti in alluminio di grandi dimensioni, a null’altro che non sia il colore bianco rosato rosa intenso quasi viola dei petali. I rami sono azzurri e sembrano fiumi, o meglio arterie che solcano un’immensa superficie rossa conducendo un fluido pastoso e innervando i petali, quasi che il punto di vista dell’artista per osservare i ciliegi non sia stato, come ci si potrebbe aspettare, dal basso all’alto oppure frontale, bensì dall’alto verso il basso, e ci trovassimo di fronte a una veduta aerea di una porzione di foresta, a una sorta di mappa geografica. In questo depistamento visivo c’è la forza di una serie di opere che superano gli ultimi tentativi pittorici di Damien Hirst, dedicati similmente ai “Cherry Blossom”, nei quali appaiono gli alberi in fiore nelle consueta prospettiva, prospettiva che dà ai suoi lavori un irrimediabile senso di déjà vu, cose già viste ma meno riuscite rispetto a quelle dei tanti predecessori nella storia dell’arte moderna (basti pensare agli “Almond blossom” di Van Gogh). La poetica di Sannino, invece, rimanda sempre a una compressione del reale negli spazi della finestra-quadro, ad una sua spettacolarizzazione nei termini soprattutto del colore: i suoi mari, le sue foreste, i panorami urbani riflettono sempre questa eccitazione visiva che, contrariamente ad Hirst, non è di maniera, semmai una vera necessità espressiva.
Nel caso degli Hanami c’è però anche tutta la storia che il termine giapponese trascina con sé e che riguarda la capacità dell’arte di creare metafore persistenti. Nel caso dell’Occidente, è la mitologia che fin dagli albori istruisce con Persefone, la dea della primavera, il nostro bisogno di comprendere il mondo, e l’alternarsi delle stagioni, e i ritmi di vita e morte. In Oriente, soprattutto in Giappone, è spesso la poesia a dar corpo a questa esigenza. Innumerevoli haiku e hokku, le stringate composizioni in 17 sillabe, molti saigo no uta, i versi di commiato dei guerrieri condannati al suicidio rituale, associano il fiore del ciliegio alla inappartenenza e alla provvisorietà del visibile, tipica della filosofia buddhista e poi zen in cui l’essere è mera apparenza e dolore dal quale possiamo allontanarci solo esperendo il vuoto e lo zero. Matsuo Bashō, il più grande poeta giapponese del Seicento, o più tardi tra Settecento e Ottocento, il monaco buddista Daigü Ryōkan, hanno cantato la rinascita, la morte, la caducità, attraverso il fiore del ciliegio e più in generale dei fiori: “Lentamente/ come la neve/ che scende dal cielo/ sembrano cadere/ i fiori del ciliegio”; “Questo mondo/ è simile all’eco/ che risuona/ e poi svanisce/ nell’aria”; “Come scrivere/ numeri sull’acqua/ è cosa vana/ affidarsi ciecamente/ al proprio cuore”; e ancora “Tutto nel mondo/ è transitorio/ e ogni essere/ va incontro/ alla morte”.
“Ogni incontro è separazione” sentenzia in limine Ryōkan; noi dal mondo, noi dalle cose. Al fondo resta però fulgida la parola che resiste e in cui riponiamo inalterata fiducia, resta il dipinto che sottrae la vita alla morte. Sannino in qualche modo riesce, attraverso l’arte, nel miracolo della rifioritura così come aveva indicato, già nel Cinquecento, il grande Arakida Moritake, autore della celebre raccolta 1000 haikai: “Un petalo caduto/ che torna al ramo:/ una farfalla”.
di Angelo Crespi